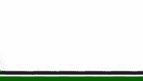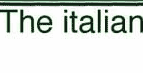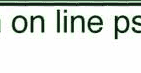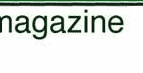|
|
|
|
|
| PSICOPATOLOGIA E ISTITUZIONE PENITENZIARIA: ANALISI STRUTTURALE DEI RAPPORTI STORICI Francesco Sanò Psicologo CONCLUSIONI Nella fase introduttiva di questo lavoro sono stati proposti alcuni criteri metodologici cui fare riferimento per valutarne la riuscita. Il primo si riferiva alla fedeltà rispetto alle fonti, intesa come accuratezza e completezza nei procedimenti di esegesi. Bisogna ammettere allora che il percorso bibliografico suggerito appare senz'altro incompleto rispetto alla vastità dei temi toccati. Il rapporto storico tra carcere e psicopatologia vede il fitto intrecciarsi di saperi quali il diritto penale e la psichiatria, la criminologia e la psicologia clinica: ognuno di questi campi avrebbe necessità in sé di svariati volumi come questo solo per indicarne i riferimenti bibliografici principali. Si è cercato invece di tenere come punto di riferimento costante per lo sviluppo del discorso la specificità dell'oggetto di studio definito dalla psicologia penitenziaria: l'uomo in quanto soggetto ad una pena, l'Homo secretus. In quest'ottica, per esempio, di tutto lo sterminato campo del diritto romano, sono stati menzionati solo quei testi, citati nel corso del lavoro, che trattassero esplicitamente della pena carceraria. Allo stesso modo si è dovuto escludere tutto l'ambito, pur attinente, riguardante la psichiatria forense e gli ospedali psichiatrici giudiziari. L'incompletezza bibliografica vuol essere allora quantomeno funzionale ad una precisa scelta argomentativa. Viene introdotto così il secondo dei criteri indicati, quello di validità interna, intesa come congruenza tra i documenti citati e le conclusioni finali. Innanzitutto va detto che come conclusioni finali non si possono che cercare le verifiche dell’ipotesi iniziale, che esista cioè una reciproca presupposizione tra pratiche penali riguardanti la reclusione e pratiche discorsive riguardanti il disturbo mentale, storicamente verificabile attraverso una serie di documenti. Si è visto come il cardine di questa interconnessione sia la funzione intrinsecamente correttiva del carcere, che ne ha permesso, nel passaggio tra i secoli XVIII e XIX, l'affermazione rispetto al tramonto delle pene corporali, a funzione didascalica. Val la pena di sottolineare che ai fini di questo lavoro non importa tanto il perché tale cambiamento si sia prodotto, ovvero la sua subordinazione ad altri tipi di mutamenti (per esempio economici), ma esclusivamente il come questo passaggio sia avvenuto, attraverso quali procedimenti. Ecco allora la descrizione della corrispondenza tra genesi del sistema carcerario moderno e tesi della Scuola positiva, che identificano nel delinquente un alienato, giustificandone la reclusione a scopo correzionale, tramandatesi poi attraverso l'eclettismo della Terza Scuola, che ne mantiene lo schema causale, accoppiandolo a quello retributivo nell'impianto differenziale del "doppio binario", sino alla normativa attuale che continua a vedere nel delinquente un disadattato, giustificandone la reclusione a scopo rieducativo. Da un periodo all'altro cambiano i termini dello schema riduzionistico, da fisiognomici, a sociologici, a psicologici, ma non cambia il meccanismo sottostante di sovrapposizione della categoria di trasgressione delle norme giuridiche a quella di trasgressione delle norme sociali. Inoltre, in antitesi con la pubblicistica storiografica specializzata, è stato dimostrato come ancora prima dell'avvento del sistema carcerario moderno, la reclusione sia sempre rientrata in questo diagramma strutturale che la interconnette alla follia, non ancora nel contesto di un’istituzione laica le cui forme d'espressione s'ascrivono al registro della "scientificità", ma attraverso una giurisprudenza sacerdotale le cui condanne corrispondono ad anatemi: la correzione reclusiva non ha qui tanto lo scopo di rieducare quanto piuttosto quello di redimere. E si noti come residui di tale concezione si siano tramandati sino a noi, codificandosi per esempio nell'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario. In Eschilo e Platone le "carenze fisiopsichiche" dell'attuale ordinamento si riflettono insomma specularmente nelle attribuzioni di e nel lessico di quella che si potrebbe considerare la "psicopatologia" dell'epoca. Ma questa ricostruzione storica non è priva di conseguenze per quanto riguarda la situazione attuale, per riferirsi così all'ultimo dei criteri di valutazione suggeriti, quello di validità euristica delle conclusioni, in termini di spunti per approfondimenti successivi, rispetto al valore puramente descrittivo di questo lavoro. L'ultima forma d'espressione in cui si estrinseca questo diagramma coinvolge infatti direttamente il ruolo dell'esperto penitenziario, che paradossalmente, si potrebbe definire "ermetico": sia in senso generale per l'ambiguità delle norme che lo definiscono, sia in senso specifico in riferimento al testo eschiliano, dove il personaggio di Ermete rappresenta il messaggero di Zeus, responsabile dell'imprigionamento di Prometeo, appositamente mandatogli allo scopo di ricondurlo all'ordine, l'unico che legga la sua ribellione in termini di pura follia. Mandatario delle istanze istituzionali, con esplicita delega di recupero , che si esplica nell'applicazione di categorie nosografiche: a distanza di 25 secoli non si può che registrare la geometrica coincidenza tra l'antica e la nuova versione della medesima istanza di ortopedia sociale. Queste considerazioni introducono poi il problema della subalternità dell’esperto nei confronti del giudice, che non si limita soltanto al piano tecnico del trattamento penitenziario, ma attiene al più vasto ambito dei rapporti disciplinari tra il carattere prescrittivo del diritto e quello esplicativo della psicologia. Si consideri per esempio che, a proposito del contrasto giuridico tra l'articolo 314 del Codice di Procedura Penale, che al 2° comma vieta la perizia sul carattere e la personalità dell'imputato, e l'articolo 133 del Codice Penale, che prescrive che il giudice nell'emissione della sentenza debba tener conto dei motivi a delinquere e del carattere del reo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 124/1970, ha così deliberato: "Il legislatore richiedendo l'indagine del giudice sul carattere dell'imputato è a posto col precetto costituzionale che pone tra le finalità della pena la rieducazione del condannato, ma non ha fiducia nella perizia psicologica (...) e perciò nega l'approfondimento di quell'indagine oltre i limiti raggiungibili dalla cultura e dall'esperienza del giudice. Verosimilmente lo domina il pensiero che lo studio della personalità dell'imputato possa venir compiuto solo da chi abbia presente il carattere afflittivo ed intimidatorio della pena, con cui la finalità di rieducazione deve essere contemperata". Nella metodologia d'intervento rispetto a spazi così definiti, tra gli obiettivi che si profilano per lo psicologo c'è quello di riuscire a restituire centralità all'utenza piuttosto che alla committenza, ribaltando la concettualizzazione della direzionalità del processo patogeno, da un percorso che conduce dalla malattia al carcere, ad uno opposto che va dal carcere alla malattia. In quest'ottica preventiva piuttosto che rieducativa, si prospetta l'esigenza di indagini epidemiologiche che accertino la consistenza presso la popolazione carceraria di fenomeni quali la depressione reattiva o i disturbi dissociativi, ancora poco studiati. In sintesi, rispetto ai criteri di fedeltà e validità sopracitati: la scelta bibliografica si propone di essere esaustiva non tanto rispetto alla varietà dei temi affrontati, quanto alla funzione di documentare in maniera sufficientemente ampia le articolazioni nello sviluppo storico del rapporto tra carcere e psicopatologia, dimostratosi coerente con le ipotesi iniziali per quanto concerne l'arco di tempo preso in considerazione, alla luce del quale sorge la necessità di un ripensamento dei compiti dello psicologo penitenziario a livello disciplinare, legislativo e clinico, nella duplice accezione più generalmente metodologica e più specificamente tecnica. BIBLIOGRAFIA AA. VV., Sul problema della rieducazione del condannato-Atti del II convegno di diritto penale, Bressanone, 1963, Cedam, Padova, 1964. AA. VV., Il carcere imperialista, Bertani editore , Verona, 1979. AA. VV., Il carcere dopo le riforme, Giuffrè, Milano, 1979. AA. VV., La prigione in Italia: storia, sviluppo, prospettive-Atti del VI Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il Trattamento dei Delinquenti, Milano, 1985, M.G.G. Centro Riproduzione, Roma, 1985. AA. VV., La formazione e l'aggiornamento del personale penitenziario, Quaderni dell'Ufficio Ricerche, Studi e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 18, 1989. AA. VV., Enciclopedia del Diritto, Garzanti, Milano, 1993. Abbate L., Capri P., Ferracuti F., La diagnosi psicologica in Criminologia e Psichiatria Forense. I tests psicologici, in Ferracuti F. (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. XIII, Psichiatria forense generale e penale, Giuffrè, Milano, 1990. Altavilla E., La psicologia del detenuto, Quaderni de "La Corte d'Assise", 3-7, 1934. American Psychiatric Association, D.S.M.-IV: manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson, Milano, 1996. Arbertario E., Delictum e Crimen nel Diritto romano-classico e nella legislazione giustinianea, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano, 1924. Aristotele (a cura di D. Lanza), Poetica, Rizzoli, Milano, 1992. Bandini T., Gatti U., La crisi dell'ideologia del trattamento, in Rassegna di Criminologia, 1, 1979. Banister P., et al., Psychological correlates of long term imprisonment, British journal of delinquency, 38, 1976. Bavaro V., Proposte per una riforma carceraria in Italia, Arti Grafiche Mario Vimercati, Milano, 1956. Beccaria C. (a cura di F. Venturi), Dei delitti e delle pene, Einaudi, Torino, 1978. Beltrani Scalia M., Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, Favale e C., Torino, 1867. Beltrani Scalia M., La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte, Artero e C., Roma, 1879. Belviso M., Ferrigno C., Scapati F., Il ruolo dell'esperto in criminologia clinica ex art. 80, comma 4, legge 26 luglio 1975 n. 354, in Rassegna di Criminologia, vol. XII, 1981. Bergeret J., Psicologia patologica, Masson, Milano, 1995. Bottardi C., Sbrana R., Di Marco E., Indagini sull'attività dell'esperto nella istituzione carceraria in rapporto all'osservazione della personalità dei detenuti, Rassegna di Criminologia-Collana monografica di Criminologia e Medicina Legale, 3, 1982. Bricola F. (a cura di ), Il carcere "riformato", Il Mulino, Bologna, 1977. Canepa G. (a cura di), Il trattamento penitenziario. Realtà e prospettive, Rassegna di Criminologia-Collana Monografica di Criminologia e Medicina Legale, 2, 1981. Canepa M., Merlo, S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 1993. Canosa R., Colonnello I., Storia del carcere in Italia, Sapere 2000, Roma, 1984. Cantele M., Jannucci, M. Dis-armati contro la giustizia: i primi passi in carcere del folle autore di reato, Il reo e il folle, n.2, 1997. Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), Carcere e società, Marsilio, Venezia, 1976. Carli R., Lo Cascio E., Un modello di analisi della violenza istituzionale: l'istituzione detentiva, in AA. VV., L'uomo e la violenza, Angeli, Milano, 1978. Carmignani G., Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Fratelli Nastri editori, Pisa, 1832. Cattaneo C., Di varie opere sulla riforma delle carceri, in Il Politecnico-Repertorio mensile di studi applicati alla prosperità sociale, vol. III, 1840. Cerri G., Il linguaggio politico nel Prometeo di Eschilo, Saggi di Semantica, Roma, 1976. Cesa Bianchi M., Psicologia generale e psicologia giuridica, Contributi di ricerca in Psicologia e Pedagogia, 3, 1994. Christie N., Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1981 Clemmer D., The prison community, Rinehart, New York, 1958. Coco N., I servizi criminologici e psicologici penitenziari, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. XI, Carcere e trattamento, Milano, Giuffrè. Cohen J., Taylor L., Psychological survival: the experience of long term imprisonment, Penguin Books, London, 1972. Colonna A., La letteratura greca, Lattes, Torino, 1977. Comucci P., Nuovi profili del trattamento penitenziario, Giuffrè, Milano, 1988. Cordero F., Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Laterza, Bari, 1985. Cremona G., voce "Psicologia carceraria", in E. Florian, A. Niceforo, N. Pende (a cura di), Dizionario di Criminologia, Vallardi, Milano, 1943. Curcio R., Valentino N., Petrelli S., Nel bosco di Bistorco, Sensibili alle foglie, Roma, 1990. Curcio R., Stati modificati di coscienza della e nella reclusione, Altrove, 5, 1998. Daga L., I sistemi penitenziari, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. XI, Carcere e trattamento, Giuffrè, Milano, 1989. De Leo G. (1987), Le istituzioni totali, in D. De Masi, A. Bonzanini (a cura di), Trattato di sociologia dell'organizzazione, F. Angeli, Milano. De Leo G. (a cura di), Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale, Giuffrè, Milano, 1989. De Leo G., Nuovi modelli di interazione fra psicologi, operatori sociali e giustizia penale, in G. De Leo (a cura di), Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale, Giuffrè, Milano, 1989. De Leo G., La psicologia clinica in campo giudiziario e penitenziario: problemi e metodi, in A. Quadrio, G. De Leo, Manuale di psicologia giudiziaria, LED, Milano, 1995. Dell'Acqua G., Mezzari R., Il folle gesto. Perizia Psichiatrica, Manicomio Giudiziario, Carcere, nell'esperienza del Servizio di Salute Mentale a Trieste, Sapere 2000, Roma, 1987. Deleuze G., Logica del senso, Feltrinelli, Milano, 1975. Deleuze G., Foucault, Feltrinelli, Milano, 1987. Deleuze G., Millepiani, Castelvecchi, Roma, 1997. De Mennato M., La psicosi della vita carceraria, Rassegna di studi psichiatrici, XXI, 1932. De Mennato M., Sulle psicosi che insorgono durante la carcerazione, Rassegna di studi psichiatrici, XV, 1937. De Robertis F. M., La funzione della pena in diritto romano, Studi Solazzi, Napoli, 1949. Di Gennaro G., Bonomo M., Breda R., Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano, 1980. Di Tullio B., Medicina pedagogica emendativa, OET, Roma, 1928. Di Tullio B., La criminalità come problema medico-sociale, Istituto di Medicina Legale, Roma, 1950. Di Tullio B., Antropologia criminale e redenzione umana, Centro internazionale di redenzione umana, Roma, 1952. Dolan B., Coid J., Psychopathic and Antisocial Personaliy Disorders, Treatment and Research Issues, London, 1993. Du Fort G., Newman C., Bland R., Psychiatric comorbity and treatment seeking: sources of selection bias in the study of clinical population, Journal of Nervous and Mental Disease, 181, 1993. Erodoto (a cura di A. Colonna e F. Bevilacqua), Le Storie, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1996. Eschilo (a cura di M. Untersteiner), Le Tragedie, Istituto Editoriale Italiano, Roma, 1947. Fassone E., La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, Bologna, 1980. Ferracuti F., Compiti della psicologia penitenziaria, La scuola positiva-Nuova serie, X, 1957. Ferracuti F., I metodi psicologici nell'azione emendativa, in M.G.G., Accademia della Magistratura, Secondo Corso di Perfezionamento per Uditori Giudiziari (30 maggio-11 agosto 1958), Giuffrè, Milano, 1959. Ferracuti F. (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. XI, Carcere e trattamento, Giuffrè, Milano, 1989. Ferracuti F., Piperno A., Dinitz S., Deterioramento mentale da detenzione. Rilevamento a mezzo di test psicometrici degli effetti della carcerazione sulle capacità mentali, Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 13, Roma, 1976. Ferrajoli L., Il diritto penale minimo, in Dei delitti e delle pene, n. 3, 1985 Ferri E., Sociologia criminale, Bocca, Torino, 1892. Ferri E., Lezioni di diritto e procedura penale, Associazione Universitaria Romana, Roma, 1911. Ferri E., Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti (Libro I) con la relazione, Vallardi, Milano, 1921. Ferrini C., Diritto penale romano, presso Pessina, Milano, 1899. Filangieri, G., La scienza della legislazione, G. Vitto, Venezia, 1784. Fornasini L., Dei pazzi e dei condannati: dei manicomi e delle prigioni, in Annali universali di medicina, vol. CXXXVI, 1848. Fossati A., Novella, L., Donati D., Maffei C., I disturbi di personalità nelle popolazioni carcerarie-una revisione degli studi epidemiologici ed una proposta di ricerca per l'Italia, Il reo e il folle, n.2, 1997. Foucault M., Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1976. Foucault M., La verità e le forme giuridiche, in A. Del Lago (a cura di), Archivio Foucault, vol. II, Feltrinelli, Milano, 1997. Foucault M., Prigioni e rivolte nelle prigioni, in A. Del Lago (a cura di ), Archivio Foucault, vol. II, Feltrinelli, Milano, 1997. Foucault M., Sulle prigioni, in A. Del Lago (a cura di), Archivio Foucault, vol. II, Feltrinelli, Milano, 1997. Gallo E., Ruggiero V., Il carcere in Europa, Bertani editore, Verona, 1983. Gallo E., Ruggiero V., Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap, Ed. Sonda, Torino, 1989. Gemelli A., Metodi, compiti e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione della delinquenza, Vita e pensiero, Milano, 1936. Gemelli A., La personalità del delinquente nei suoi fondamenti biologici e psicologici, Giuffrè, Milano, 1948. Giancane S., Prevalenza dell'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope fra i detenuti extracomunitari nuovi giunti del carcere di Bologna, Boll. Farmacodip. Alcool, n. 4, 1996. Giusti G., Bacci M, Patologia del detenuto e compatibilità carceraria, Giuffrè, Milano, 1991. Goffmann I., Asylums. Le istituzioni totali, Bompiani, Milano, 1969. Gonin D., Il corpo incarcerato, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1994. Grassi A., Tossicodipendenti detenuti: analisi psicodinamica e descrittiva per l'individuazione di idonei programmi socioriabilitativi, Psichiatria e Psicoterapia Analitica, n. 13, 1944. Guagliardo V., Dei dolori e delle pene, Sensibili alle foglie, Roma, 1997. Gulotta G.. La psicologia giuridica: un'introduzione, in G. Gulotta (a cura di), Psicologia giuridica, Angeli, Milano, 1979. Gulotta G. (a cura di), Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè, Milano, 1987. Gunn J., Robertson G., Psychopatic personality: a conceptual problem, Psychological Medicine, 6, 1976. Hulsman, L., The abolitionist Case: Alternative Crime policies, Israel Law Review, 1991. Ignatieff M., Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, 1750-1850, Mondadori, Milano, 1982. Lacan J., Introduzione teorica alle funzioni della psicoanalisi in criminologia, in Scritti, Einaudi, Torino, 1974. Lattanzi G., La personalità del condannato nel regime penitenziario italiano, in AA. VV., Delitto e personalità, Giuffrè, Milano, 1955. Lazzari R., Ferracuti F., Rizzo G.B., Applicazione della Scala Wechsler Bellevue forma I su un gruppo di detenuti italiani, Rassegna di studi penitenziari, 1958. Lombroso C., L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie, Bocca, Torino, 1878. Longo G., La repressione della violenza nel diritto penale Romano, in AA. VV., Studi in onore di Gioacchino Scaduto, vol. III, Cedam, Padova, 1970. Mantovani F., Il problema della criminalità, Cedam, Padova, 1984. Marotta, G., Bueno Arus, F., Le basi giuridiche del trattamento penale, in F. Ferracuti, Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatri forense, vol. XI, Carcere e trattamento, Giuffrè, Milano, 1989. Marugo M.I., La crisi del trattamento in istituto. Aspetti teorici ed applicativi, in G.B. Traverso (a cura di), Criminologia e psichiatria forense, Giuffrè, Milano. Mathiesen, T., Perché il carcere, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1996. Matza D., Come si diventa devianti, Il Mulino, Bologna, 1976. Mecacci L., Storia della psicologia del Novecento, Laterza, Bari, 1992. Melossi D., Pavarini M., Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario, Il Mulino, Bologna, 1977. Mereu I., Storia dell'intolleranza in Europa, Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas s.p.a., Milano, 1990. Merzagora I., Il colloquio criminologico, Unicopli, Milano, 1987. Merzagora I., Controllo sociale, psicopatologia e punizione, Rivista di Psicologia Giuridica, 1, 1997. Mosconi G.A. (a cura di), L'altro carcere, Cleup, Padova, 1982. Neppi Modena G., Carcere e società civile, in Storia d'Italia, V, Einaudi, Torino, 1973. Nivoli G. C. (1980), Il colloquio criminologico, in G. Trentini, Manuale del colloquio e dell'intervista, Mondadori, Milano. Novelli G., Primi lineamenti di una teoria della individualizzazione della pena nelle sue tre fasi: legislativa, giudiziale, esecutiva, in AA, VV., Studi in onore di Mariani d'Amelio, vol. II, Roma, 1933. Pantosti G., Pellegrini E., Fare lo psicologo nel sistema penitenziario per gli adulti, in G. De Leo (a cura di), Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale, Giuffrè, Milano, 1989. Patrizi P., Psicologia giuridica penale. Storia, attualità, prospettive, Giuffrè, Milano, 1996. Pavarini M., L'esecuzione della pena, in F. Bricola (a cura di), Codice penale. Parte generale, UTET, Torino, 1983. Persico G., La riforma del sistema penitenziario italiano particolarmente in rapporto alla personalità del condannato, in AA. VV., Delitto e personalità, Giuffrè, Milano, 1955. Plato (by R.G. Bury), Laws, William Heinemann ltd., London, 1961. Platone (a cura di A. Cassarà), Le Leggi, Cedam, Padova, 1947. Podlecki A. J., The political background of Aeschilean Tragedy, Ann Arbor, 1966. Ponti G., Droga e criminalità, Archivio di Medicina Legale Assicurativa, n. 3, 1974. Pugliese G., Diritto criminale romano, in AA. VV. (a cura di V. Ussani e F. Arnaldi), Guida allo studio della civiltà romana antica, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, Napoli, 1958. Renazzi, Ph. M., Elementa iuris criminalis, ed. De Dominicis, Napoli, 1788. Ricci A., Salierno G., IL carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria, Einaudi, Torino, 1971. Robins L.N., Epidemiology of antisocial personality, in O.J., Cavenar (a cura di), Psychiatry, vol. I, Lippincott & Co., Philadelphia, 1985. Romagnosi G. D., Genesi del diritto penale, Stamperia Piatti, Firenze, 1844. Rossi E., Tossicodipendenti in carcere, in F. Ongaro Basaglia, M.G. Giannichedda (a cura di), Psichiatria, tossicodipendenze, perizia. Ricerche su forme di tutela, diritti, modelli di servizio, Angeli, Milano, 1987. Rusche G., Kircheimer O., Pena e struttura sociale, Il Mulino, Bologna, 1978. Salvini A., La psicologia nei suoi rapporti con la giustizia penale: appunti per un cambiamento paradigmatico, in M.P. Cuomo, G. La Greca, L. Viggiani (a cura di), Giudici, psicologi e delinquenza giovanile, Giuffrè, Milano, 1982. Santalucia B., Diritto e processo penale nell'antica Roma, Giuffrè, Milano, 1989. Scardaccione G., Una valutazione critica del trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti normali e infermi di mente, Quaderni di Criminologia Clinica, 4, 1978. Sclafani F. (a cura di), Il problema penitenziario in Italia. Rassegna bibliografica (1980-1984), Rassegna di Criminologia-Collana Monografica di Criminologia e Medicina Legale, 5, 1986. Serra C. (a cura di), Psicologia e giustizia. Questioni di psicologia giuridica, Giuffrè, Milano, 1980. Serra C. (a cura di), Devianza e difesa sociale, Angeli, Milano, 1981. Serra C. (a cura di), L'istituzione penitenziaria come comunicazione: ipotesi, esperienze, prospettive- Atti del IV Congresso nazionale del Coordinamento Esperti Istituti Di Prevenzione e Pena, Messina, 1984, Rassegna penitenziaria e criminologica, numero speciale, 1984. Serra C. (a cura di), Criminalità, carcere e recupero sociale, Kappa, Roma, 1987. Serra C., Lo psicologo e il carcere, in G. Gulotta, Trattato di psicologia giudiziaria nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1987. Serra C., Istituzione e violenza, Libreria di Psicologia, Roma, 1990. Serra C., Il Castello, San Giorgio e il drago. Depressione reattiva; autolesionismo e suicidio in carcere, SEAM, Roma, 1994. Serra C., Lo psicologo nel processo di trattamento penitenziario nel settore adulti, in A. Quadrio, G. De Leo (a cura di), Manuale di psicologia giuridica, LED, Milano, 1995. Serra C., La pena e la sua esecuzione, in Atti del convegno Psicologia giuridica e responsabilità, Torino, 21-22 Marzo 1998, non pubblicato. Sommer R., Osmond H., Symptoms of istitutional care, Social Problem, vol. 8, 1961. Taylor A., Social Isolation and imprisonment, Psychiatry, 363, 1961. Tito Livio (a cura di N. Scarano), Storia Romana, libro terzo, Carlo Signorelli Editore, Milano, 1934. Tucidide (a cura di G. Donini), Le Storie, UTET, Torino, 1982. Veno A., Peke H.V.S., O'Sullivan M., Tuller I.R., L'influenza del carcere sulla condotta violenta, Quaderni di Criminologia Clinica, 4, 1974. Valentino N., Ergastolo, Sensibili alle foglie, Roma, 1994. Voci P. Istituzioni di diritto romano, Giuffrè, Milano, 1996. | POL.it è organizzata per rubriche e sezioni affidate a Redattori volontari che coordinano le varie parti della Rivista. Anche tu puoi divenare collaboratore fisso o saltuario della testata, scrivi utlizzando il link proposto sottto, dando la tua disponibilità in termini di tempo e di interessi, verrai immediatamente contattato. Come tante realtà sulla rete POL.it si basa sul lavoro cooperativo ed è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori, certi come siamo che solo un allargamento della cerchia dei suoi redattori può garantire alla Rivista la sua continua crescita in termini di contenuti e qualità. ti aspettiamo..... |
![]()

![]()