 | 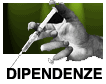 | 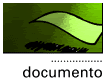 | 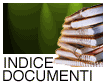 |  |  | 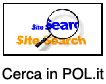 |
 |
|
|||||||
|
|
ASPETTI TERAPEUTICI DELLE TECNICHE ESPRESSIVE NEL TRATTAMENTO DI GIOVANI CON DIPENDENZE PATOLOGICHE Nicola Bussolati1, Umberto Nizzoli2 1Psicologo, Psicoterapeuta, A.U.S.L. Reggio Emilia
PREMESSA L'esperienza diagnostica e clinica presso il Sert di Reggio Emilia assieme all'analisi degli studi scientifici e dei dati epidemiologici di origine americana ed europea ci ha portato a riflettere sull'incremento della problematica legata alla dipendenza patologica in adolescenza anche in considerazione delle precoci età di prima assunzione. Quest'aspetto unito alla constatazione empirica e sperimentale che le condotte trasgressive in adolescenza accrescono le successive assunzioni di rischio, ci hanno condotto a pensare alle conseguenze sulle strategie di trattamento. Un rapporto della Columbia University relativa all'anno 1996 rivela che nella quasi totalità (79%) dei diciassettenni ha avuto contatti con l'alcol e una parte beve in modo problematico, il 25% usa marijuana e altre droghe, il 20% fuma tabacco quotidianamente e il 10% usa eroina crack e LSD. In aggiunta a ciò l'età di inizio dell'uso di sostanze è drammaticamente scesa. Dal 1992 al 1996 la percentuale di tredicenni che utilizzano o hanno già utilizzato la marijuana sale dal 7.7% al 12.7%, l'età media di accesso all'uso della marijuana è scesa dai 17.6 del 1979 ai 16.3 del 1994. Dal 1990 al 1994 l'età media del primo uso di alcol e scesa dagli 16.5 anni ai 15.9, l'uso quotidiano di sigarette da ai 18.9 ai 16.8. Una ricerca sui ragazzi dai 9 ai 12 anni ha verificato il raddoppio dal 2 al 4% di un uso di marijuana a quelle età tra il 1995 e il 1996 e del passaggio dal 2% al 3% a nell'uso di cocaina tra il 1993 e 1996. Gli adolescenti italiani di una ricerca svolta dall'U.S.L. di Ferrara mostrano differenze con segno positivo rispetto all'uso di tabacco e alcool e sembrano un po’ meno inclini all'uso di stupefacenti anche se questo può essere spiegabile con una reticenza a parlarne (Boncompagni, 1994). Uno studio effettuato dal Sert di Reggio Emilia sui giovani frequentatori della locale Festa dell'Unità e i primi risultati di una ricerca condotta assieme al Comune di Reggio Emilia sulle condotte di dipendenza adolescenziali hanno prodotto risultati assimilabili a quelli americani. Per quanto riguarda le patologie associate al consumo di droghe De Milio (1989) ha riscontrato, su un campione di adolescenti abusatori di sostanze ricoverati valutati con il sistema diagnostico DSM III-R, la presenza di 35% di disturbi dell'umore, 14% di disturbi da deficit dell'attenzione, un 7% di disturbi della condotta con crisi pantoclastiche, un 16% di disturbi di personalità, 7% di fobie e un 7% di disturbi schizofreniformi. Sempre De Milio ha riscontrato nel 42% degli adolescenti tossicofili il disturbo della condotta con o senza aggressività. Il Monitoring the Future Study dell'Università del Michigan rivela un impressionante incremento dei ragazzi che hanno compagni tossicomani dalla 39% al 56% tra il 1996 e il 1997 e contiene indici che rivelano un declino nella percezione del rischio connesso all'uso di sostanza. È provato, infatti, che la percezione del rischio negli adolescenti ha struttura bifattoriale, in cui l'entità del pericolo oggettivo e l'influenza dei pari costituiscono gli elementi favorenti l'incremento o la diminuzione dei comportamenti trasgressivi (Savadori e Rumiati 1996). In aggiunta a ciò, il comportamento d'uso di sostanze retroagisce positivamente sull'ottimismo ingiustificato rispetto ai rischi amplificando la tendenza ad assumerne altri (Ibidem). Aspetti teorici della dipendenza in adolescenza Freud definisce l'adolescenza "una delle più significative, ma anche più dolorose prestazioni psichiche della pubertà, il distacco dall'autorità dei genitori, che produce il contrasto, così importante per il progresso civile, della nuova con la vecchia generazione" (Freud, 1905). Secondo Blos (1973) si caratterizza per essere una seconda fase di separazione individuazione preparatoria l'assunzione di responsabilità nell'età adulta. Distacco dall'autorità genitoriale, separazione affettiva dagli oggetti d'investimenti infantili da una parte e spinta all'individuazione dall'altra, danno luogo ad un contrasto interno tra bisogni di dipendenza e desiderio d'autonomia che spesso esita in comportamenti trasgressivi o assunzioni di rischio. Come sostiene Nizzoli (1997) "spinte regressive e spinte propulsive alla crescita si mescolano con la sfida della paura e la ricerca del piacere". Jeammet (1993) sottolinea come "la percezione della dipendenza affettiva e del proprio sentimento d'insufficienza ed impotenza" espongano l'adolescente al vissuto essenziale della dipendenza, in altre parole a "una passività caratterizzata dal desiderio di ricevere e di esser riempito dal ciò che proviene da fuori, dal mondo degli adulti". Questo avviene perché l'adolescente è in grado, a differenza del bambino, per il quale la dipendenza è una necessità biologica, di utilizzare un corpo maturo che gli consentirebbe una potenziale autonomia. Il contrasto tra questa maturità biologica ed una più o meno accentuata immaturità affettiva è la matrice delle instabilità e dei disagi che possono condurre ad una soluzione comportamentale. Quando la dipendenza vissuta è forte, il desiderio d'autonomia adolescenziale diventa impellente e assume contorni del bisogno, trasformando il necessario superamento delle autorità genitoriale in conflitto opposizione. Come fa rilevare Jeammet (1993) questa opposizione diviene appoggio conflittuale in quanto non riconoscibile; il riconoscimento del bisogno avrebbe infatti come esito quel vissuto di insufficienza impotenza da cui l'adolescente dipendente si difende. L'opposizione permette invece di negarlo (io non sono come loro i genitori) e nel contempo dà appoggio alla nuova malferma identità. Se il contrasto con l'autorità genitoriale, corroborato da alcuni atti trasgressivi, appartiene alla norma dell'adolescenza (Guidi 1997) osserviamo però tutte quelle situazioni d'interesse clinico, dove trasgressione comportamentale e dipendenza negata si saldano per dar luogo ai disturbi della condotta, alle tossicodipendenze, ai disturbi alimentari. Sono le situazioni in cui la ricerca di una propria "autoritas" che prenda il posto di quella genitoriale è inibita o spenta sul nascere da un bisogno di rassicurante presenza fisica dell'oggetto d'amore. Colpa e angoscia di abbandono troppo forti hanno impedito nell'infanzia il processo di "reverie" sostituendolo con un bisogno percettivo di oggetti concreti. Il controllo si sostituisce allora al desiderio, la realtà del bisogno alla fantasia. In questa situazione ogni atto d'individuazione diventa pericoloso per la possibile perdita oggettuale. Il comportamento trasgressivo diviene allora ripetitivo, si trasforma in neo oggetto sostitutivo degli oggetti parentali, ma anche strumento di mediazione con loro (Fain, 1980). La separazione viene così scongiurarla e la falsa indipendenza della trasgressione diviene simulacro di un'autonomia impossibile. Eppure la ripetizione compulsiva dell'assunzione del rischio rivela "una ricerca, non una semplice fuga dalla sofferenza, ma un tentativo di passaggio, di morte e di rinascita, di accesso ad un mondo migliore" (Nizzoli, 1996). Ma l'assenza dell'oggetto non è pensabile e quindi indicibile la necessità della sua presenza fisica ne rende improbabile la rappresentazione. Quel processo di elaborazione che, dal piacere condiviso, porta al dolore per l'assenza (nostalgia) e alla sua evoluzione creativa (autorità) in un nuovo inizio è impensabile, inaccessibile (Bussolati, 1993).. Come sostiene Jeammet (1993) "ogni piacere ha una fine, la non soddisfazione invece non ne ha ed offre una risposta terribilmente efficace alle angosce di castrazione ed abbandono". Il corpo è spesso il teatro del comportamento dipendente e lo è come luogo di sensazioni e di auto boicottaggio. Il corpo sessuato è, infatti, il potenziale artefice di quell'autonomia pericolosa, di quel passaggio temuto dalla sensazione al sentimento che sancirebbe l'individuazione. Nelle tossicomanie adolescenziali, nelle bulimie e nelle anoressie, nel comportamento sessuale a rischio, è attaccato e controllato un corpo vissuto come ancora appartenente ai genitori (Laufer, 1986), come merce di scambio affettivo, fonte di sensazioni atte a coprire temporaneamente un'insopportabile assenza. Il rischio, non è, infatti, la distruzione di un corpo non vissuto come proprio, ma la perdita e l'assenza oggettuale. Questa perdita esita in un processo di rifiuto del corpo, di parte di esso o di sue funzioni che consente l'affermarsi di un'identità negativa che non ha debiti con l'oggetto. Nel contempo questo processo ha funzione di terzo mediatore con gli oggetti parentali e di tramite linguistico con il gruppo del pari. Le particolari condizioni della dipendenza in adolescenza richiedono un approccio psicoterapeutico dove "il recupero dell'attività di rappresentazione e il piacere del funzionamento mentale" (Jeammet, 1993), l'individuazione e la definizione degli affetti vengono prima dell'interpretazione del conflitto che necessita di un confronto inabilitante con le debolezze narcisistiche. Le attività espressive si svolgono spesso in un contesto protettivo rispetto all'angoscia d'abbandono, quale può essere un centro diurno dove il contenimento è realizzato senza operare un distacco del paziente dalla famiglia (De Wit, 1993). Tali tecniche possono, utilizzando i canali non verbali della comunicazione, porre le basi per l'attivazione o riattivazione di quel processo di elaborazione necessario alla crescita individuale. Sono inoltre particolarmente indicate per favorire lo sviluppo dell'empatia con i terapeuti nei pazienti giovani che mostrano diffidenza nei confronti dell'adulto (Peloquin,1996;De Wit, 1993). Per tecniche espressive s'intendono quelle forme di supporto alla psicoterapia che utilizzano le arti visive la musica e la corporeità. Arte terapia, teatro terapia, musicoterapia, sono alcune di queste tecniche, dove l'accento dell'intervento viene posto sull'elicitazione delle potenzialità creative del paziente attraverso l'uso di canali espressivi spesso diversi dalla parola e più vicini ai codici comunicativi primari. Il laboratorio teatrale ad esempio "utilizzano più di una logica, più di un canale espressivo e apre all'integrazione di diverse istanze cognitive, emotive, intuitive, creative; sul piano temporale (passato, presente, futuro); sul piano relazionale (io-tu, interno-esterno); sul piano corporeo (vissuti di piacere e integrazione)" (Cavallo 1998). Possiamo convenire che tecniche di questo genere si addicono alle esigenze terapeutiche dei pazienti oggetto di questo scritto. L'espressione di sé su vari canali comunicativi, guidata da un esperto in situazione di gruppo, favorisce, infatti, da una parte la decolpevolizzazione del comportamento espressivo (è un gioco, una farsa, lo fanno anche gli altri) dall'altra permette di scoprire parti di sè inesplorate e affrontare blocchi emotivi spesso declinatisi sul corpo, sulla postura o sull'espressione verbale senza doverli interpretare subito. È questa una dimensione dove il piacere di rappresentare prevale sulla spiegazione e rinforza così le basi dell'autostima, proprio in quel territorio, il corpo (buco), i sensi (stordimento), bersaglio dell'azione tossicomanica. Se l'adolescenza, come sostiene Blos, è una seconda individuazione e la tossicodipendenza interpreta un bisogno di rinascita (Zoia, 1985), in entrambe il corpo gioca un ruolo centrale e può mobilitare o incistare il processo d'individuazione. "I laboratori teatrali invece diventano luoghi dove si rifanno i corpi, liberando l'uomo dai suoi automatismi; il cliente attore modifica e modella tre dimensioni del corpo: il vissuto, la rappresentazione, l'utilizzo " (Cavallo, 1998) nell'ottica di un'espansione delle "superfici di sensibilità" (Jouvet, 1989). La rappresentazione di sè, del proprio vissuto, attraverso i gesti, i movimenti, la voce e anche il linguaggio, nel suo aspetto analogico ed evocativo, è uno strumento essenziale per prendere distanza dalle paure e identificare le emozioni e i sentimenti che costituiscono il sé ri-nascente del giovane in trattamento terapeutico. L'agire teatrale si sostituisce il modo evolutivo all'acting mentre la sperimentazione ed espansione di nuovi aspetti di sé rimpiazzano simbolicamente e, di fatto, la trasgressione. In questo senso il teatro utilizza un linguaggio idoneo e comprensibile rispetto allo stile d'azione e al bisogno di trasformazione adolescenziale. L'adolescente tossicomane con la sua scarsa capacità di fantasmatizzare e di rappresentare tende, come abbiamo visto, a collocare il rischio fuori da un corpo vissuto come estraneo. La possibilità di vivere una dimensione emozionale più ampia, l'affrontare in situazione protetta le paure connesse ai propri sentimenti, può rimodulare il registro interno della percezione di rischio verso una direzione più realistica. Una sperimentazione delle proprie potenzialità creative fornisce invece una base di partenza per un reale processo di individuazione, ricollocando la percezione di pericolo al livello dei comportamenti di auto-boicottaggio e delle condotte trasgressive. In altri termini il circolo vizioso comportamento trasgressivo versus assunzione di rischio può essere interrotto con il recupero, supportato dalle tecniche espressive, di una rappresentazione di sé narcisistica mente significativa che vale la pena di difendere. IL centro diurno Socrate è una struttura semi-residenziale del Sert di Reggio Emilia dove i pazienti adolescenti o giovani adulti, con problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti e/o ai disturbi del comportamento alimentare, usufruiscono, accanto a gruppi educativi e terapeutici, di atelier espressivi. Gran parte delle attività programmate passano attraverso una dimensione di gioco e di sperimentazione, per consentire alle persone di fare le cose per il piacere di farle. Gli operatori aiutano i ragazzi a sperimentare la loro creatività negli atelier "con l'intento di fornire a ciascuno la possibilità di rappresentare a sé e agli altri la propria esperienza di vita passata e presente" (Nizzoli, 1996). I cicli di attività sono organizzati in modo da pervenire ad un obiettivo di integrazione delle varie esperienze fatte in atelier al fine di dare ai pazienti una percezione unitaria dei vissuti sperimentati nelle attività. Un esempio è costituito dagli incontri per una performance sulla " La maschera della morte rossa" dal testo di Edgar Allan Poe. "L'intenzione era quella di corteggiare la paura partendo da prospettive diverse, scatenando diverse strategie di sondaggio fantastico, aprendo all'immaginario, al vissuto e al rimosso i territori del corpo, quelli della parola e quelli della materia plasmabile: creta, carta, stoffa, colore ecc." (Zelioli et. altri, 1996). Il corteggiamento della paura mirava a favorire la percezione emotiva del rischio e a rappresentarla, per svincolarla gradualmente dai fantasmi abbandonici restituendola al dato di realtà delle condotte di auto-sabotaggio. Gli interdetti educativi del programma hanno senso se i limiti sono percepiti come protettivi rispetto al rischio reale insito nell'uso di sostanze. D'altro canto la realtà del rischio può essere percepita solo quando le paure inconsce rappresentate e gestite lasciano spazio a un'idea di sé cui il paziente attribuisce un valore. Il percorso si è svolto nei vari atelier che converge vano sul canovaccio dello scritto di Poe. Nell'atelier di cultura sono stati dedicati cinque incontri con i pazienti alla disamina dell'idea di paura, cercando di disegnarne la mappa immaginaria, fatta di luoghi, situazioni, definizioni, associazioni. Sono usciti temi della paura rispetto al tempo, allo spazio, la paura nel corpo e nell'anima. Ciascuno ha cercato poi di legare ad ogni nome un'esperienza, di trovare a ciascuna esperienza una spiegazione. Lo sforzo sì è quindi incentrato sulla ricostruzione dei procedimenti che innescano e sostengono le esperienze narrative della paura; alla fine è stato proposto a tutti pazienti la lettura in comune del racconto di Poe. L'atelier di espressività corporea in cinque incontri paralleli ha condotto un'esperienza di sensibilizzazione e di educazione al movimento, una sorta di breve cammino guidato alla scoperta del potenziale euristico ed espressivo del corpo quando si rende disponibile alle stimolazione dell'anima. L'atelier di arti figurative porta parallelamente i pazienti ad elaborare ciascuno una propria intuizione visiva della paura creando le maschere da usare successivamente nella performance che si preoccupa di disegnare gli spazi del centro scegliendo ed organizzando i percorsi d'ambientazione necessari ad esprimere, nelle condizioni descritte, la paura. Dopo queste fasi preparatorie gli atelier si sono legati in un lavoro comune che ha riunito materiali visivi, emozionali, intellettuali e gestuali, nella rappresentazione del racconto. L'uso del video registratore ha permesso di documentare il lavoro ma anche di frazionare i momenti creativi senza che la parcellizzazione significasse dispersione e discontinuità dei risultati. Così ciò che si andava raccogliendo scena per scena, per unità sopportabile di lavorazione, è stato infine selezionato e restituito ad un assetto accettabile di senso grazie al montaggio e alla verbalizzazione in gruppo. Gli effetti del lavoro di preparazione e della performance stessa si sono potuti osservare sui pazienti nei termini di un forte ingaggio di gruppo e di un sensibile aumento della produzione verbale all'interno dei gruppi educativi e terapeutici. L'attività espressiva integrata ha dato voce e parole a sentimenti prima negati o non codificabili aprendo così la strada all'interpretazione e al cambiamento. Blos P. (1973): The function of the ego-ideal in adolescence in The psychoanalitic study of the child, Hogarth Press, London. Boncompagni G. (1995) in Personalità / Dipendenza n.1 anno 1, Mucchi, Modena. Bussolati N. (1993): Amore e dipendenza: la nostalgia impossibile Quaderno di psicoterapia n.2 Regione Emilia Romagna Commission on American Substance Abuse (C.A.S.A.) (1997): Adolescent Commission Report, Columbia University, http.//www.casacolumbia.org/pubs/aug97/contents.htm Cavallo M. (1988): Il laboratorio teatrale, ovvero il teatro come tecnologia del sé Catarsi i teatri della diversità, Cooperativa Magma, Pesaro. David C. Kay (1985): Substance abuse in psychopathic states and sociopathic individuals in Substance abuse and psychopathology, Plenum Press, New York. De Wit J, Der Veer Guus (1993): Psicologia dell'adolescenza, Giunti, Firenze. Freud S. (1925): Inibizione sintomo e angoscia, in Opere, vol. 4, Boringhieri, Torino. Guidi N. (1997): Trasgressione e rischio in adolescenza Psicoterapia e scienze umane n. 2. Jeammet Ph. (1993): Adolescenza e dipendenza Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza vol 60: p 3-14. Jouvet L. (1989): Elogio del disordine, La casa Usher, Firenze. Laufer M, Laufer M.E. (1986): Adolescenza e breakdown evolutivo, Boringhieri, Torino. Nizzoli U. (1996): Prendersi cura dei tossicodipendenti, Masson, Milano Nizzoli U., Pissacroia M. (1997): Gli atteggiamenti tossicofilici in adolescenza in Trattato di psicopatologia dell'adolescenza, Piccin, Padova. Peloquin S.M.(1996): Art: an occupation for developing empaty American Journal of Occupational Therapy Savadori L., Rumiati R. (1996): Percezione del rischio negli adolescenti italiani Giornale Italiano di Psicologia, anno XXIII, n. 1. Zelioli S. , Cervi R., Laganà L. (1996): Le attività espressive al centro diurno: un incontro tra psicoterapia e progetto educativo Relazione tenuta al Convegno Intermedia di Rimini


|